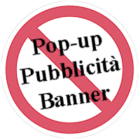We Are The World è finita

Nel 1985, in tutte le radio del mondo, si poteva ascoltare una, se non più volte al giorno, la canzone che divenne una delle hit più famose degli anni ’80: We Are the World. Tutti ricordano il brano e l’altrettanto celebre videoclip, scritto da Michael Jackson e Lionel Richie e prodotto da Quincy Jones. Per l’occasione fu creato il supergruppo composto da 45 artisti USA for Africa con l’obiettivo di raccogliere fondi, attraverso le vendite del disco, per la popolazione etiope, allora colpita da una devastante carestia.
Nello stesso anno, Bob Geldof (cantante dei Boomtown Rats) e Midge Ure (cantante e chitarrista degli Ultravox) riuscirono a concretizzare un’altra grande iniziativa: il concerto Live Aid, organizzato contemporaneamente al Wembley Stadium di Londra e al John F. Kennedy Stadium di Philadelphia. L’evento fu seguito in diretta da quasi due miliardi di telespettatori.
Questi due momenti rappresentano un esempio di condivisione e solidarietà: la musica si presta a essere veicolo umanitario e strumento di unione tra le persone. Ancora oggi questi concerti restano una testimonianza vivissima della coesione tra gli artisti per obiettivi comuni di giustizia sociale.
Oggi, quarant’anni dopo, lo scenario appare molto diverso.
Nel 2022, i concerti in Polonia dell’ex Pink Floyd Roger Waters sono stati cancellati a causa delle polemiche suscitate dalle sue posizioni sulla guerra in Ucraina. La controversia nacque da una lettera aperta che Waters scrisse alla first lady ucraina, nella quale accusava alcuni nazionalisti estremisti di aver trascinato il Paese nella guerra disastrosa tuttora in corso e rimproverava al presidente Zelensky di non aver mantenuto la promessa elettorale di portare la pace nel Donbass.
Quella lettera spinse il consiglio comunale di Cracovia ad approvare una risoluzione per dichiarare Waters persona non gradita, con tanto di invito pubblico da parte di un consigliere al boicottaggio dei concerti.
L’artista britannico ha sempre palesato le sue critiche e il suo disprezzo per le guerre, sia verso il conflitto russo ucraino che verso Israele: «ciò che gli israeliani fanno ai palestinesi è simile a ciò che gli ebrei dovettero subire nella Germania degli anni ’30», disse in un’intervista del 2013. Waters ha sempre sostenuto pubblicamente la causa palestinese, arrivando a chiedere a colleghi come Neil Young e Bon Jovi di non suonare a Tel Aviv.
Nel 2023, in Germania, un’alleanza di gruppi ebraici chiese la cancellazione di un suo concerto previsto a Francoforte, accusandolo di antisemitismo e di aver esercitato pressioni sui musicisti che intendevano suonare in Israele. Diversi artisti, tuttavia, come i Red Hot Chili Peppers, si sono sempre esibiti in Israele. Per Tom Yorke dei Radiohead, suonare in un Paese non significa approvare il suo governo.
Celebre anche il contrasto tra Nick Cave e Waters, sempre sulla questione israeliana: Cave sostiene che boicottare Israele, da lui definita una vera democrazia, sia vergognoso e codardo. Esibirsi nel Paese, afferma, non significa approvarne le politiche, ma connettersi con i propri fan. Waters, invece, ritiene che farlo equivalga ad avallare 75 anni di occupazione sionista.
Nell’aprile 2025, furono cancellati in Germania due concerti della band irlandese The Murder Capital, colpevole di voler esporre sul palco la bandiera palestinese. I musicisti rifiutarono la richiesta di rinunciarvi, e i locali il Gretchen di Berlino e il Gebäude 9 di Colonia annullarono gli spettacoli.
In Italia, intanto, esplosero polemiche attorno al viaggio e al concerto di Al Bano e Iva Zanicchi in Russia, accusati di essere complici morali di chi sostiene gli aggressori nella guerra contro l’Ucraina e di voltarsi dall’altra parte di fronte alla tragedia del nostro tempo.
Nel luglio 2025 è stato poi annullato un atteso concerto alla Reggia di Caserta del direttore d’orchestra russo Valery Gergiev, uno dei più grandi protagonisti del panorama sinfonico mondiale. La sua colpa sarebbe stata di non aver mai condannato pubblicamente l’operato di Vladimir Putin in Ucraina. Forse ci si era dimenticati che Gergiev non veniva certo per discutere di politica internazionale o di annessioni, ma semplicemente per dirigere un’orchestra.
Simile il caso nel 2022 dello scrittore Paolo Nori, che da anni si dedica alla divulgazione della cultura russa in Italia. All’Università Bicocca di Milano avrebbe dovuto tenere un corso gratuito su Dostoevskij, ma pochi giorni prima dell’inizio ricevette un’e-mail che ne chiedeva il rinvio per evitare ogni forma di polemica interna in un momento di forte tensione internazionale. A poco servì annullare la decisione presa inizialmente di sospendere il seminario: l’ascia della censura era ormai palesemente dissotterrata, e così replicò lo scrittore: «...censurare un corso è ridicolo. Non solo essere un russo vivente è una colpa oggi in Italia ma anche essere un russo morto, che, quando era vivo, nel 1849, è stato condannato a morte perché aveva letto una cosa proibita. Che un’università italiana proibisca un corso su un autore come Dostoevskij è una cosa a cui io non posso credere».
Anche la cantante lirica russa Anna Jur’evna Netrebko, naturalizzata austriaca e considerata una delle più grandi interpreti della sua generazione, è stata coinvolta in boicottaggi: dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina, alcuni teatri in America e Germania cancellarono i suoi spettacoli per la presunta vicinanza al Cremlino.
Nella città dei fiori, durante il Festival di Sanremo 2024, il cantante di origini tunisine Ghali dichiarò sul palco: «stop al genocidio». L’ambasciatore israeliano Alon Bar reagì definendo le sue parole vergognose, accusando il festival di diffondere odio e provocazioni. La RAI prese posizione con un comunicato in cui dichiarava che la solidarietà al popolo di Israele e alla comunità ebraica era sentita e convinta.
In quell’occasione, nessuna grande voce del mondo musicale si levò in difesa dell’artista tunisino.
Eppure, oggi, molti di quegli stessi artisti sventolano la bandiera palestinese. Gli equilibri internazionali cambiano, e ciò che prima poteva comportare rischi professionali ora potrebbe anche risultare vantaggioso. Forse alcuni hanno compreso che sostenere la causa palestinese sia una scelta popolare, ma, del resto, come rimanere indifferenti di fronte a un’indiscutibile catastrofe umanitaria?
L’artista, in un mondo ideale, dovrebbe essere sempre libero di esprimersi nella propria performance: accoglienza, rispetto e pace possono nascere solo dal non giudicarlo per le sue posizioni ideologiche, ma per la bellezza che porta nel mondo con la sua arte. Perché, come cambiano velocemente le direzioni dei venti, così mutano anche le opinioni delle masse e, di conseguenza, il giudizio del pubblico verso gli artisti.
Un giudizio che, purtroppo, spesso non si limita all’arte e che è facilmente orientabile da chi decide come e cosa si deve pensare; oggi, con la tecnologia di cui disponiamo, questo controllo è ancora più semplice e capillare. E non c’è bisogno della coercizione plateale e visibile come poteva accadere qualche decennio fa nella ex Repubblica Democratica Tedesca. David Bowie nel 1977 con Heroes, ispirandosi a due ragazzi che si baciavano vicino al Muro di Berlino, ci offre un piccolo affresco di ciò che fu la Guerra Fredda con i due blocchi contrapposti: Occidente e URSS. All’epoca, la Stasi, la polizia segreta della Germania Est, decideva le vite delle persone e controllava la popolazione in modo oppressivo; nella quarta di copertina del libro della scrittrice Anna Funder, C’era una volta la Ddr, una frase ironica e sarcastica basta a farci entrare in quel mondo: «la Stasi sapeva tutto di tutti, ma, ossessionata dai dettagli, fallì nel prevedere la fine del comunismo».
Nessun popolo occidentale oggi accetterebbe un regime tanto oppressivo come quello della ex Ddr, così come il regime del ventennio in Italia, ma la volontà di controllare opinioni, pensieri e comportamenti resta una costante del potere. Con i mass media, i social network e la sovrainformazione che ci bombarda senza sosta, è fin troppo facile costruire opinioni di massa.
Dopo la Seconda guerra mondiale, si dice che Churchill abbia commentato: «In Italia c'erano 45 milioni di fascisti; dal giorno dopo, 45 milioni di antifascisti. Ma non mi risulta che l'Italia abbia 90 milioni di abitanti». Una frase impietosa che fotografa come sia facile il cambio di casacca di una nazione e il conseguente mutamento radicale del pensiero politico.
Ed ecco allora che entra in scena il mondo artistico, della musica, del cinema, con i vari personaggi che possono sposare una causa o l’altra. Qual è quella giusta? Quella che viene veicolata ed accettata dalla maggior parte delle persone, che sono poi autorizzate a condannare con la gogna mediatica chiunque differisca dal pensiero unico, o quella supportata dalle posizioni che in quel momento sono in minoranza?
La narrazione dominante, plasmata dagli interessi geopolitici, è ormai capace di modificare in pochissimo tempo le convinzioni delle masse. Personaggi ed eventi vengono amplificati, riempiendo giornali, social e programmi televisivi, in un vortice di opinioni preconfezionate.
L’epoca di We are the world è passata, il muro di Berlino è crollato da più di tre decenni, gli artisti uniti per una causa apolitica non vanno più di moda.
In questo scenario, se non praticheremo l’ascolto, il confronto e il riconoscimento dell’altro, anche di chi ci appare diverso o non conforme, sarà davvero difficile, forse impossibile, costruire un mondo di pace.