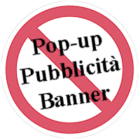Bruce Springsteen and The E-Street Band 2025 World Tour
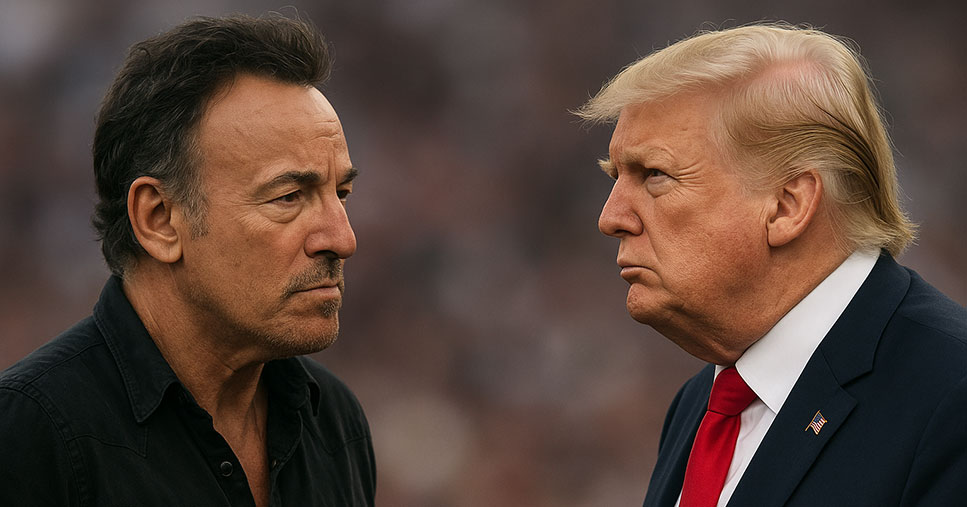
Ebbene sì, sono stato uno dei 65.000 che il 21 giugno del 1985 ha partecipato al primo concerto di Bruce Springsteen in Italia, nello stadio di San Siro, quando gli anelli erano ancora due e il prato del tempio del calcio era ricoperto da una semplice retina verde, i cui buchi ti permettevano di strappare un po’ d’erba del sacro suolo del tempio del calcio milanese e di portatela a casa come un trofeo. Una passione, quella per Bruce, cominciata nel 1981, quando mio fratello più grande portò a casa il doppio album di The River, una cornucopia di sonorità americane che rivestivano canzoni fresche, cantabili, con testi narrativi e lirici.
Dal country al doo-wop, dal rock’n’roll al folk, una band rodata già da due lunghi tour pronta a distribuire al mondo quell’enciclopedia di stili, vero nutrimento emotivo e musicale per la gioventù di allora. John Lennon fece in tempo a commentare l’album (che usci due mesi prima della sua tragica morte) dicendo che Hungry Heart “è il miglior singolo mai uscito dai tempi dei Beatles”. E The River è anche un album con un significato nell’economia della crescita autorale di Springsteen, perché fa da spartiacque tra gli album giovanili – Greetings from Asbury Park, The Wild, The Innocent and the E-Street Shuffle, Born to Run, Darkness on the Edge of Town – carichi di impazienza, sete di vita, tensione e domande vergate con le esperienze più che con le parole e gli album della consapevolezza – Nebraska, Born in the USA e Tunnel of Love – dove sull’uomo sembra incombere il tragico destino di un sogno destinato sistematicamente ad infrangersi o perdersi come polvere nel vento.
Nel passaggio tra la prima e la seconda fase, Springsteen passa dalla frequentazione dei B-Movie americani, che gli fornivano materiale per titoli di canzoni e storie d’amore semiclandestine, alla letteratura americana di Steinbeck e ai primi cantautori impegnati. Ottima sintesi di questa ricerca evolutiva è la canzone This Hard Land, scritta verso il 1982, ma pubblicata solo molti anni dopo, una ballad in tutto e per tutto dylaniana con un testo narrativo ricco di immagini e con quel motto finale (“Stay hard, Stay hungry, Stay alive…”) che riassume il significato dell’esistenza che rimbalza tra speranze e fallimenti con l’obbligo - che a poco a poco si scopre cristiano - di non mollare mai.
A partire da queste brevi note nasce e si consolida il mito di Springsteen nell’immaginario collettivo: certo, un grande performer e leader, pieno di carisma e di sensualità, che fonde il miglior Elvis col miglior James Brown, passando per Johnny Cash e Van Morrison, ma soprattutto un artista che buca ogni schermo interiore e ti prende il cuore, dandoti la sensazione che quella canzone l’ha scritta pensando proprio a te. Insomma, un talento munifico, che cresce di album in album e te lo senti vicino. Per questo, ancora oggi, quando arriva in Italia, tocca sorbirsi quei post di chi dice che Springsteen gli ha salvato la vita, che di per sé non significano niente di concreto, ma rendono l’idea di quando nel più profondo scoramento, nella più criptica solitudine, nella più sconfortante anomia, ti aggrappi a una canzone - e spesso sono canzoni sue - di Bruce Springsteen.
E fin qui tutto bene, nel senso che Springsteen è il fratello maggiore, il padre, il professore, il vicino di casa, l’amico che non abbiamo mai avuto ma sappiamo che esiste. Però la mitopoiesi del personaggio porta, almeno in Italia, all’impossibilità di criticarlo, parlarne male, sottoporlo a valutazioni artistiche. Come accadde, in tempi e per ragioni diverse, a Celentano, Jovanotti, Paolo Conte ecc,, ecco che anche Springsteen qualunque cosa faccia è giusta e perfetta, al punto che la community dei fan di Springsteen si qualifica per talebanismo ad oltranza, assenza totale di competenza musicale e spesso i fan non si rendono conto che sono molto più presi dal personaggio Springsteen che dalle sue opere. Quindi nessuno si accorge se Bruce ha la voce calante, se Steve Van Zandt va per i cavoli suoi, se Max Weinberg cicca qualche bracciata o se Nils Lofgren fa tremila note senza espressività. Tutte cose umane che possono succedere, ma non se ne parla, non se ne può parlare, non se ne deve parlare.
Ed è quello che è accaduto quest’anno, ovvero 40 anni dopo quel giugno 1985, sempre a San Siro, ma non per ragioni musicali. La scaletta è stata buona e non scontata, la performance apprezzabile in rapporto all’età media dei musicisti, ma c’è stato un elemento di disturbo che non legava per niente con lo spettacolo. Mi riferisco alle concioni politiche anti Trump utilizzate per introdurre canzoni scritte in altri tempi e per altre ragioni, asservite a una polemica politica demagogica e sterile senza capo né coda. Concioni pronunciate in inglese e tradotte sui maxischermi in italiano. Tesi presentate come apodittiche, vere e proprie sentenze, senza alcuna contestualizzazione precisa, pronunciate come si fa in un comizio senza contraddittorio. E lo trovo assurdo.
Siamo tutti al corrente dalla ruggine atavica tra Springsteen e Trump, ma che senso ha portare per il mondo uno spettacolo musicale in cui ci sono siparietti elettorali carichi di terrore e tremore, con accuse al limite della denuncia? Quelli come me che hanno acquistato il salatissimo biglietto quasi due anni fa, volevano e si aspettavano questo? Siamo seri: assolutamente no. Eppure dai giornaloni e dai social nemmeno uno straccio di commento. Tutto vero, tutto sacrosanto, tutto artistico.
Personalmente ho trovato addirittura offensivo che una canzone come Land of Hope and Dreams, un gospel che ha un antecedente preciso nella musica religiosa (This Train is Bound for Glory di Sister Rosetta Tharpe), scritta dal Boss alla fine degli anni 90, sia diventata una canzone di resistenza anti-trumpiana, così come My City of Ruins, presente su The Rising del 2002, album della resilienza post 11 settembre. Sono solo due esempi che mi rammaricano, perché tolgono poesia, magia e coerenza a un momento comunitario musicale che assume una valenza quasi liturgica proprio perché va oltre le divisioni di ogni tipo. Oltretutto rivelando il limite di Springsteen di essere un americano fatto e finito – USAcentrico – che non si chiede se gli USA fanno bene al mondo con la loro aggressività consumistica, la geopolitica fondata su armi, finanza e accaparramento di materie prime, le destabilizzazioni territoriali, le guerre preventive. No, a lui importa che il miliardario cafone volgarotto biondo diventi nostro nemico, ma non si chiede cosa pensassimo del demente senile col pannolone che c’era prima di Trump. Insomma, in questo, Springsteen si rivela uomo della sua generazione, abituato all’idea degli USA poliziotto del mondo, regolatore delle contese internazionali, signore di un mondo unipolare.
Ecco, di tutto questo non c’è traccia nei giornali, social network ecc.: niente di niente. E mi fa male dover scrivere questo pezzo, dopo aver visto in questi 40 anni almeno 15 concerti del Boss incarnare l’essenza più pura della gioia di sentirsi parte della razza umana attraverso la musica più bella del mondo. Springsteen ha 76 anni, soffre da decenni di depressione, sua moglie soffre di un cancro aggressivo dal 2018, la sua adorata madre è morta nel 2024. Non so, forse per tirare avanti c’è bisogno anche di avere un nemico. Ma sul treno di cui canta Springsteen in Land of Hope and Dreams (contrariamente al gospel originale) si salvano tutti, anche i peccatori, i bari e le anime perdute. E allora ripartiamo da qui, da quella scintilla che la buona musica può innescare per renderci fiamma dello stesso fuoco che brucia di un amore sano: l’amore del perdono.