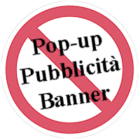SMiLE, la sinfonia adolescenziale di Brian Wilson

“Brian Wilson è un autentico genio musicale — e su questo non si discute. Ci sono momenti in SMiLE talmente straordinari che potresti ritrovarti a fissare gli altoparlanti in uno stupore puro e inatteso, come è successo a me. I Beach Boys e i Beatles erano consapevoli l’uno dell’altro e spinti entrambi da una motivazione feroce. La grande differenza? Il numero di fuoriclasse: i Beatles avevano due songwriter mostruosi come Lennon e McCartney, e un grande talento come Harrison. I Beach Boys avevano Brian Wilson”
Henry Rollins
Nel 1967, mentre i Beatles rivoluzionavano il pop con Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band, Brian Wilson inseguiva un sogno ancora più grande. Più visionario, più fragile, più pericoloso. Quel qualcosa avrebbe dovuto chiamarsi SMiLE e planare sui giovani dell’epoca come una Teenage Symphony to God. Ma non accadde. O meglio, non subito. Sarebbe stato l’album più rivoluzionario della musica pop, ma SMiLE venne accantonato, sostituito in fretta e furia da un surreale simulacro lo-fi di nome Smiley Smile. Eppure, nei decenni successivi, SMiLE acquisì una nomea quasi chimerica: un capolavoro perduto, un Santo Graal musicale posto sull’irraggiungibile vetta della montagna che la musica popolare avrebbe scalato per mirare orizzonti lontanissimi.
Nel 1966 Brian Wilson aveva già intagliato Pet Sounds, e i Beatles ne rimasero folgorati. Paul McCartney lo considera il capolavoro dei capolavori, ammettendo che un’elegia del calibro di God Only Knows lo fa piangere ad ogni ascolto. Anche George Martin ammise candidamente che Sgt Pepper's altro non fosse che un tentativo di emulazione del capolavoro dei Beach Boys. Pet Sounds, però, avrebbe dovuto essere solo l’anticamera. SMiLE doveva andare oltre sotto ogni aspetto: compositivo, filosofico, sonoro. Tuttavia, mentre il progetto si ampliava e assumeva le sembianze di una cattedrale sonora modulare, la psiche di Brian cominciava a cedere. L’LSD, la marijuana, l’insonnia, le voci nei nastri, le crisi paranoiche, i sabotaggi interni alla band, e il timore (fondatissimo) che i Beatles stessero per fare prima e meglio, lo condussero lentamente alla paralisi creativa.
Quando Sgt. Pepper’s fu pubblicato il 1° giugno del 1967, Brian si chiuse in se stesso. Disse solo: «They did it first» e SMiLE fu abbandonato, restò incompiuto. Sarebbe stata un’opera mistica in forma di collage sonoro. Una serie di quadri – a volte narrativi, a volte astratti – uniti da un’architettura a blocchi che anticipava tecniche di montaggio che sarebbero divenute abituali solo decenni dopo nella musica elettronica e ambient.
SMiLE doveva essere un coacervo di simboli e metafore. Un viaggio nella mitologia americana e la testimonianza di una spiritualità laica, la celebrazione dell’innocenza perduta e la rappresentazione dei quattro elementi della natura in brani allegorici; soprattutto, la trasposizione in musica dell’io spezzato di Brian Wilson, con interludi schizofrenici, sussurri d’infanzia, melodie spezzate e sezioni corali provenienti da chissà dove.
Invece da quel naufragio spirituale e artistico nacque solo Smiley Smile: un corpo franto che conteneva appena le scintille del sogno originario. Pubblicato nel settembre del 1967, sembrava quasi una caricatura allucinata dell’opera incompiuta. I pezzi erano in parte gli stessi – Heroes and Villains, Wonderful, Wind Chimes, Vegetables – ma era come se fossero stati rivisitati da una mente sotto tranquillanti, registrati in una casa affittata a Los Angeles invece che nei templi sonori della Capitol Records.
Smiley Smile era lo spettro di un capolavoro abortito. Una versione smontata, rarefatta, decomposta, quasi disturbante nella sua placida stranezza. Là dove SMiLE prometteva un viaggio sinfonico e lisergico, Smiley Smile offriva un’esperienza più intima, disarmonica, frammentata. Un disco che pareva uscito da una comune di freak spiritualmente esausti, intento a sussurrare all’orecchio di un mondo che faceva troppo rumore per ascoltare.
Solo nel 2004, dopo ben trentasette anni, Brian Wilson trovò il coraggio di chiudere il cerchio. Brian Wilson Presents SMiLE non fu la semplice riesumazione di un progetto incompiuto, ma una resurrezione. Con la collaborazione della sua nuova band e del fidato Van Dyke Parks, poeta colto, surrealista, linguista della psichedelia, a cui furono affidati i testi, l'uomo ormai invecchiato e sopravvissuto ai propri abissi tornò su quelle architetture interrotte, ricostruendo pezzo dopo pezzo l’impianto immaginifico del 1967. Ne uscì un’opera finalmente compiuta, trasparente, limpida, dolorosamente luminosa. Non lo SMiLE del 1967, ma la sua versione possibile nel mondo reale: l'eco rifratta di un sogno divenuto finalmente racconto.
Eppure, al di là della dimensione biografica e quasi psicanalitica del progetto, Brian Wilson Presents SMiLE è prima di tutto un’opera di straordinaria potenza musicale. È il trionfo della forma che si fa contenuto, dei lessemi del pop traslati in utopia sinfonica. Ogni brano è un mosaico costruito con precisione meticolosa: il collage sonoro, che negli anni ’60 pareva folle e frammentario, viene qui ordinato in una narrazione coerente, ma non per questo razionale. Un viaggio orchestrato nei territori del mito americano, della memoria e della trascendenza, con una struttura tripartita che corrisponde idealmente ai tre movimenti dell’opera classica.
La strumentazione è sontuosa ma mai ridondante. Gli archi non coprono, accompagnano. Gli ottoni esplodono come fanfare antiche e lontanissime. Gli strumenti giocattolo, i legni, le campane, le armonie vocali a più strati – marchio di fabbrica dei Beach Boys – vengono cesellati con una lucidità che nel 1967 sarebbe stata impossibile. Wilson, ormai sobrio e assistito da una band in stato di grazia, riesce a plasmare un suono che è al contempo fedele alla visione originaria e consapevole della distanza temporale che da essa lo separa. Non è nostalgia, bensì esecuzione postuma di un’opera mai nata, e in questo paradosso risiede la sua grandezza.
I testi di Van Dyke Parks si rivelano nella loro interezza: barocchi, assurdi, ricchi di ellissi e allitterazioni, attraversati da immagini che sembrano uscite da un sogno collettivo americano pervaso di nonsense. Sono columnated ruins domino, rovine colonnate che cadono come tessere, metafora enigmatica del declino dell’America industriale.
In Cabin Essence, tra martelli ritmici e cori spettrali, si celebra e insieme si decostruisce l’epopea della conquista ferroviaria. In Heroes and Villains, con il suo andamento a saliscendi e i suoi incastri da operetta psichedelica, si mette in scena una commedia dell’identità, una parabola western deformata, fatta di soldati, tende da circo e stazioni deserte.
In Surf’s Up, brano simbolo e vertice spirituale del disco, la voce di Brian – ora meno cristallina ma più consapevole – intona versi che paiono scritti da un poeta simbolista naufragato nel dopoguerra: «Una canzone per bambini / Hai mai ascoltato mentre giocano? / La loro canzone è amore / E i bambini conoscono la via».
C’è spazio anche per il grottesco e il surreale, come in Vegetables, parodia bucolica che diventa meditazione zen sul corpo e la natura, o in Wind Chimes, dove le campanelle tintinnano come presagi, tra dolcezza infantile e inquietudine cosmica.
Ma è Good Vibrations, inserito come gran finale e ripensato in questa veste, a riassumere il senso profondo del lavoro: il pop perfetto divenuto immortale, il singolo da classifica che muta in sinfonia interiore, quintessenza dell’arte wilsoniana.
Il valore di Brian Wilson Presents SMiLE è inestimabile (al di là delle tre candidature ai Grammy Awards e del premio per la Best Rock Instrumental Performance) perché non appartiene più solo alla sfera musicale. È un documento di guarigione, un lascito culturale, una dimostrazione che la bellezza può sopravvivere al tempo, alla follia, al fallimento. È la prova che un capolavoro può attendere quarant’anni per venire al mondo e, nel farlo, mantenere intatta la sua aura.
In un'epoca in cui la musica popolare si è ridotta a mero prodotto, SMiLE rimane un gesto: irripetibile, anacronistico, necessario. Non ci restituisce il 1967, ma ci dà la possibilità – unica e commovente – di abitare per un’ora un mondo altro, dove le melodie innalzano e l’ascolto diventa rivelazione.